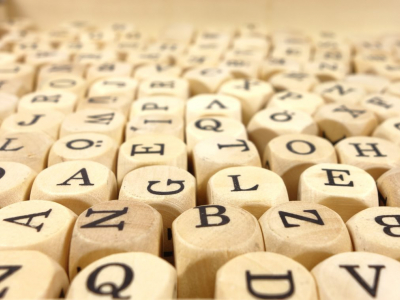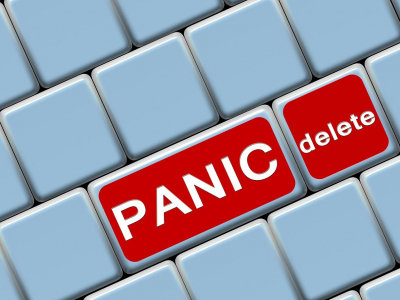La pandemia del Covid-19 ha modificato la nostra vita e le nostre relazioni facendoci sentire sempre più ansiosi e depressi. Come fare per ritornare a vivere?
Il nostro mondo è cambiato
Anche se ci sforziamo di vivere una normalità rassicurante, anche se ci sforziamo di evitare l'irrompere dei fatti di cronaca sulla pandemia nella narrazione della nostra giornata, il nostro mondo è cambiato. Non è solo all'esterno, al "fuori di noi", che penso (a cui mi riferisco), ma anche al nostro mondo "interno" e a ciò che questo cambiamento comporta. Non poteva essere altrimenti dato che ogni individuo è, per tutta la sua vita, immerso in due tipi di relazioni:
-
quella con sè stesso
-
quella con altro da sè.
Sono aspetti aspetti interconnessi e ogni accadimento, in una di queste due aree relazionali, influenza il nostro modo di vivere l'altra. Le esperienze esterne hanno risonanza interna; le esperienze interne, intese come gli accadimenti dell'intrapsichico, danno formula alla nostra maniera di leggere il mondo e al nostro agire.
Il pericolo che stiamo vivendo si connota per una generale sensazione di catastrofe incombente. Ognuno a suo modo si è trovato a respirare un'aria di calamità che, chiudendo alla visione del futuro, annienta il desiderio.
Quando il desiderio va in crisi, va in crisi la vita
Desiderare nella sua etimologia si compone di "de", prefisso che indica sottrazione e "sidus" che significa stella, quindi letteralmente significa "senza stelle". I popoli antichi volgevano gli occhi al cielo per conoscere o propiziarsi il futuro, quindi desiderare ha il significato di smettere di guardare le stelle a scopo augurale, sentire la mancanza.
Afferma Recalcati: "Finché c'è il desiderio c'è la vita". Parafrasando questa affermazione, si potrebbe dire che, in assenza di vita, scompare il desiderio. Non dirigiamo più il nostro sguardo verso le stelle. Questo è ciò che è avvenuto nelle vite delle persone in tempi di Covid. Accade in questo modo che un evento estraneo, inaspettato, di grande impatto emotivo, agisca sul nostro più profondo sentire.
Allora come e quanto un evento esterno a noi può diventare sconvolgente?
Per capire come, dobbiamo fare un passo indietro e andare all'opera di Freud del 1919 dal titolo "Il perturbante". In quel libro Freud riprende un concetto utilizzato dallo psichiatra Ernst Jentsch qualche anno prima e lo sviluppa alla luce della sua teoria psicoanalitica. Jentsch aveva scritto il libro "Sulla psicologia dello sconosciuto", nel quale rilevava l'effetto disturbante che viene generato nell'osservatore da alcuni comportamenti non consueti, come quelli di una persona con crisi epilettica o con una psicosi e che lo stesso effetto si ha leggendo racconti fabtastici, i cui personaggi risultano essere ambigui, al limite tra animato e inanimato.
Citando, a riprova della sua tesi, il racconto fantastico di Hoffmann "L'uomo della sabbia" e il personaggio di Olympia, che nel racconto sembra figura indefinibile, persona reale e bambola contemporaneamente, Jentsch afferma che ciò non è consueto, familiare, porta turbamento e incertezza intellettuale. Freud estende la tesi di Jentsch e nota che non tutto quello che è sconosciuto genera turbamento e che quando ci accade non si tratta solo di incertezza intellettuale, ma di angoscia.
Egli rileva che il termine "familiare", heimlich in tedesco, ha annche significato di celato, nascosto. Difatti scrive nella sua opera: "Heimlich è, quindi, un termine chee sviluppa il suo significato in senso ambivalente, fino a coincidere, in conclusione, col suo contrario, unheimlich, che in tedesco ha il significato di familiare e terrifico al tmpo stesso". La parola perturbante nella lingua italiana è la parola che più si avvicina al significato che Freud intendeva. Per Freud, quindi ciò ch è unheimlich emerge dal rimosso ed è generatore di angoscia.
Il tema della morte
Tornando ai nostri giorni, possiamo affermare che, se fino al secolo scorso la morte era rito collettivo, la nostra cultura occidentale ha sviluppato verso la morte, negli ultimi decenni, una sorta di rimozione collettiva: non si vuole invecchiare, non si vuole essere malati e non si vuole morire. Ci siamo invece abituati alla "morte finta" nel cinema, nei videogiochi, oppure ad osservarla da lontano, nelle notizie dei telegiornali o dei vari altri media.
Abbiamo coltivato l'illusione dell'eterna giovinezza e della salute perpetua. Allora la malattia e la morte, che tanto prepotentemente sono entrate nella nostra vita, sono unheimlich: turbano la nostra coscienza. Il Covid-19 ci ha traumaticamente riportati alla nostra natura di esseri biologici, sottoposti ai suoi fenomeni: si nasce, ci si ammala, si muore. Ci ha costretti a confrontarci con un fantasma di morte, la nostra e quella di chi amiamo, quando invece "ognuno di noi è inconsciamente convinto della propria immortalità (Freus, Al di là del principio del piacere).
L'eccezionalità della situazione che stiamo vivendo, il fortissimo impatto emotivo generato, riportando ad un evento traumatico collettivo. La psicoanalisi ci ha insegnato che ogni evento traumatico porta la psiche ad attivare alcuni meccanismo di difesa: di questi, la rimozione è princeps inter pares, primo tra i pari.
Per capire quanto, quindi, ci spingiamo proprio nel sentiero della rimozione e della sua relazione con l'io. L'io è l'stanza che presiede, nella nostra psiche, alla relazione con la realtà. Osserva e valuta gli accadimenti interni ed esterni a noi. La rimozione è funzione dell'Io ed entra in gioco ogni volta che viene attivata l'angoscia, quindi, in questo caso la possibilità di morte. Abbiamo detto che malattia e morte sono unheimlich e il rimando è ncora a Freud: "La sensibilità verso quel sentire è sollecitata in maniera diversissima da individuo a individuo". Quanto più forte abita in noi l'angoscia della morte, tanto più potente è la nostra difesa verso essa. Ecco che la malattia e la morte annullano il desiderio, soverchiato e offuscato da una angoscia di morte.
Però il desiderio è irriducibile al bisogno, afferma Lacan, perché non consiste in una relazione con l'oggetto reale ma nasce, invece, nella relazione con l'Altro. È presa d'atto di una mancanza, il desiderio è desiderio dell'Altro, non è sostituibile con gli oggetti. Anche se nella società moderna siamo stati abituati a pensare che il desiderio sia desiderio di oggetti, la psicoanalisi ci dice che è desiderio di relazione con altro da sè.
Il desiderio non è il bisogno, che una volta soddisfatto cessa di essere avvertito, è invece una mappa del nostro modo di essere e di sentire, mappa che alimenta la motivazione, e ciò ci porta fuori e ci spinge ad agire. Proprio azione e relazioe in tempi di Covid sono venuti a mancare, sostituiti dalla paura dell'altro, che va tenuto lontano per paura del possibile contagio e dalla paura di agire o meglio dal divieto di agire.
Azione e relazione: da lì nascono le emozioni che colorano la vita. La nuova "legge" dell'isolamento forzato, con il conseguente cambio delle abitudini, ha aumentato la sofferenza psichica in una vasta fascia della popolazione. Sintomi di ansia, depressione o umore basso, unitamente a rabbia, frustrazione e insonnia si sono diffusi. Diventa difficile trovare le risorse dentro di noi per far fronte a tutto questo.
Bisognerebbe non soffermarsi sulla paura ma sfruttare il momento di sosta per coltivare quella parte di noi che, spesso, non prendiamo in considerazione. Bisogna imparare a so-stare, saper rimanere dentro un periodo di incertezza e cercare di entrare in contatto con le emozioni che ci abitano alla ricerca della serenità perduta, alla ricerca di un nuovo equilibrio. Mai come in questo momento è importante coltivare la nostra capacità di entrare in contatto con noi stessi, perché..."il desiderio, forse, è il dono che nessun altro dono può soddisfare" (Emily Dickinson).



 VIALE ROCCO LARUSSA 51 -
89018 Villa San Giovanni (RC)
VIALE ROCCO LARUSSA 51 -
89018 Villa San Giovanni (RC)
 Richiedi visita
Richiedi visita